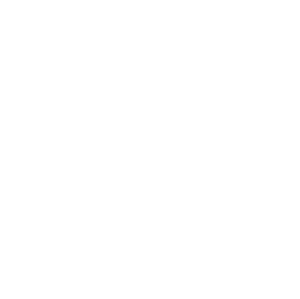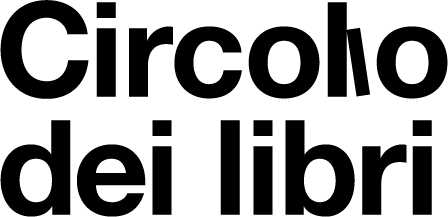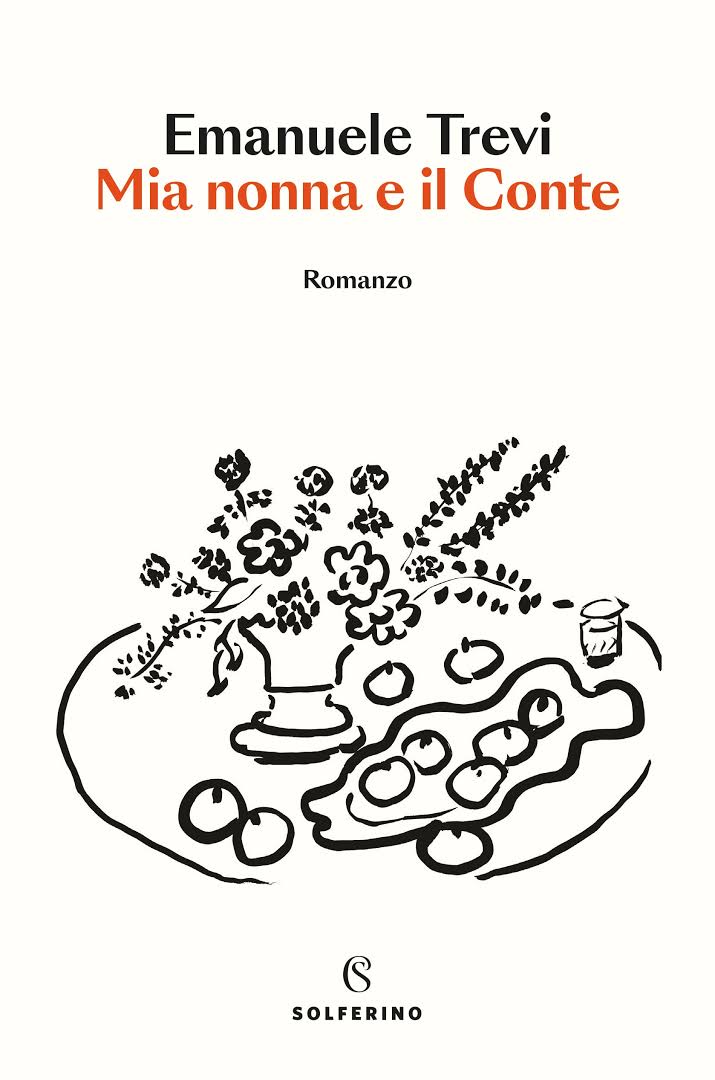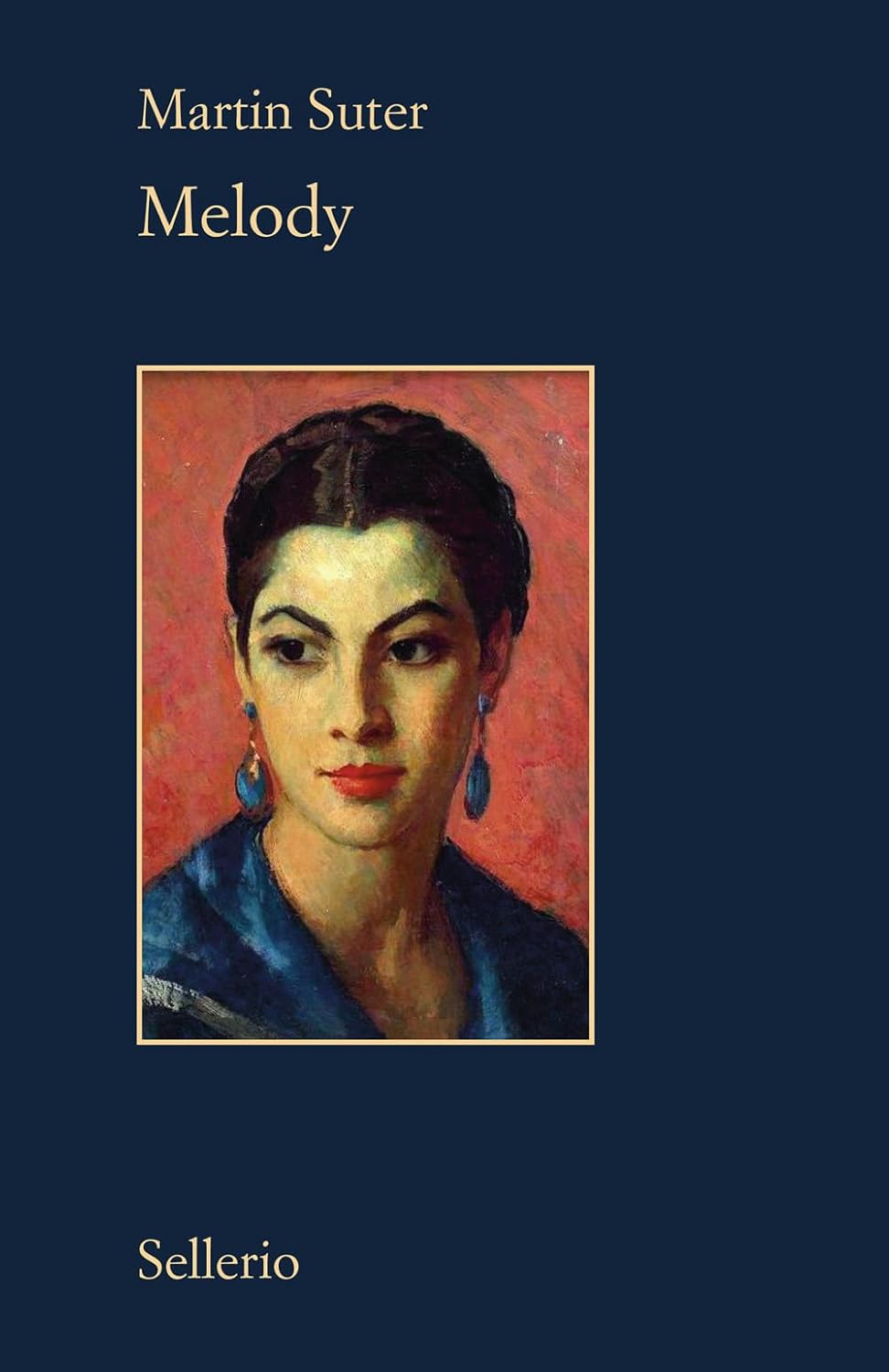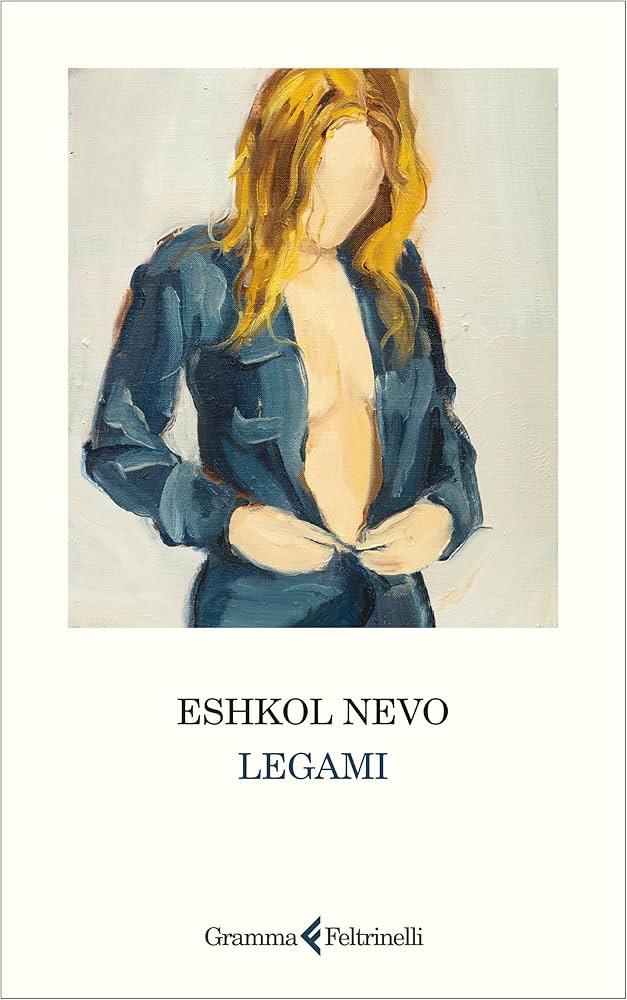Marta Morazzoni
Guanda
Marta Morazzoni torna, a quarant’anni dal suo felice esordio narrativo con la raccolta “La ragazza col turbante” e dopo una decina di apprezzati romanzi, alla misura del racconto. E lo fa confermando la propria scrittura accuratissima, modulata con sensibilità quasi musicale, mescolando tonalità, accenti, coloriture con grande attenzione. Qui si tratta di sette storie spesso allusive, con snodi accennati, che potrebbero essere qua e là degli “essais” di romanzi possibili ma non scoccati, laddove le trame sono labili, sfrangiate fra detto e non detto, volutamente. Ho già scritto che stilisticamente Morazzoni è una delle migliori penne (o si dice oggi tastiere?) della narrativa italiana. Se le sue storie sono spesso avvolte nel pulviscolo di una vaghezza allusiva, di una ambiguità ben calcolata fra i fatti e la loro memoria - e la loro netta spiegazione risulta volutamente un po’ nascosta - per contro il linguaggio è preciso e sciolto ma controllato e senza mai cedere al sentimento facile. La lettura ne risulta gradevole e impegnativa al tempo stesso. Gradevole perché la scrittura di Morazzoni è di taglio alto ma anche limpida, rigorosa, spesso armoniosa in senso proprio musicale, appunto. Ma dicevo che la lettura di questi racconti è anche impegnativa perché Morazzoni non fa sconti al lettore e lo invita a un suo lavoro partecipativo di mente e di cuore, con rimandi a lampi culturali, quasi come un nutrimento, un “fil rouge” di sensibilità intellettuale: e sono echi di romanzi, opere liriche, teatri, autori e titoli, anche di quelli tosti, da piani alti. Il primo racconto, per esempio, è un biglietto da visita non facile e tuttavia coinvolgente perché il lettore condivide con l’io narrante della protagonista l’irto e decisivo percorso formativo (culturale e esistenziale) dettato da un personaggio misterioso, presente in modo forte ma anche obliquo, sfuggente: è quello di Vinia, donna coltissima e stravagante che fa da Pigmalione a una giovane ancora digiuna di scalate acculturate; e la ragazza, alla scuola della strana e sfuggente Vinia imparerà, crescerà, consoliderà la sua formazione (o conversione?) culturale e grazie indirettamente alla Maestra conoscerà anche fugaci relazioni con maschi non di carta. Il racconto impegna il lettore perché lo accompagna dentro questo cammino formativo: leggendo, si prendono volentieri annotazioni con una matita su un bloc notes, come impegni di approfondimento, di un prossimo futuro di conoscenze, pronti a farsi catturare da piste nuove (come fa del resto la protagonista del racconto, di cui non si può ignorare la traccia autobiografica). Se uno poi (altro esempio) al termine di un racconto giapponese di straordinaria atmosfera (lievità e chiarità, gesti rarefatti e aggraziati) scopre che lo strano viaggiatore occidentale che risale una collina nipponica in una dolce bruma serale verso una dimora misteriosa alla ricerca di una traccia amorosa perduta si chiama Pinkerton, di colpo gli si muove dentro la memoria della “Madame Butterfly” e scopre che il racconto della Morazzoni inventa un secondo, immaginoso e malinconico ritorno in Giappone del personaggio pucciniano. E, ancora, la fugace esperienza amorosa giovanile di una ragazza italiana che si innamora di uno studente tanto bello quanto egoista e fuggiasco e trascura l’amore sincero di un uomo meno affascinante ma più vero, richiama per chi sa (e fa scoprire a chi non sa) il nesso curioso con “Il velo dipinto” di Maugham, laddove una adultera si perde un attimo con un amante inaffidabile e mascalzone non accorgendosi dell’amore più discreto e quasi celato, ma più profondo e vero, del marito. È anche un gioco seducente, quello di Morazzoni. E così uno dei racconti più belli della sua raccolta è quello che davvero potrebbe diventare persino un romanzo, narrando una vicenda che ruota prima, durante e dopo attorno a un periglioso e drammatico volo su un piccolo aereo da turismo e rivela alla fine una traccia di storia vera, con due nomi e cognomi illustri e reali. In questo caso Morazzoni ha dunque ritagliato dalla realtà una cellula di cronaca vera per tesserle intorno una bella storia di sguardi laterali, di coincidenze fatali. Cito per finire, fra i sette racconti, quello del goffo ragazzo cinefilo che si consola della sua amara vita mediocre e anaffettiva con la passione ossessiva per il grande schermo (anche qui un bell’elenco da cineclub). Inutile apparirà l’illusione di saldare la finzione del cinema con l’esperienza vera di un contatto reale, effettivo e affettivo. Sette racconti: in ognuno affiorano punti di svolta, piccoli enigmi; e le tonalità della scrittura alludono, dicono e talvolta non dicono.
Gary Shteyngart
Guanda
Ecco un romanzo che spiazza e intriga, e anche diverte seppure con una vena di allarmata malinconia: è un’avventura familiare dentro un futuro prossimo negli Stati Uniti, diciamo fra circa una ventina d’anni o anche meno. Gary Shteyngart, scrittore americano ma nato russo, segue con simpatia lo sguardo sul mondo di Vera, una bambina di 9 anni (per la quale il mondo poi si riduce alla famiglia, alla scuola, a qualche amica o amico). Ci sono due piste narrative bene intrecciate in questo bel libro singolare: una è la cosiddetta trama lineare, l’altra è l’ambientazione culturale e sociale. Proprio lo sfondo ambientale inietta nella storia un suo linguaggio, un suo codice espressivo da società americana avanzata, post- post moderna, in ogni caso post trumpiana senza che le tracce tardive dell’odierno Trump siano svanite del tutto. La storia, innanzitutto, appena abbozzata qui: Vera sta in una famiglia benestante progressista degli States, è intelligentissima e i suoi fieri e trepidi genitori la iscrivono a una scuola per superdotati. Vera è figlia di primo letto di suo padre, un russo ebreo diventato americano, un intellettuale buono ma pasticcione e un po’ perennemente in crisi. La madre, che la bambina non ha mai conosciuto, era coreana, e risulta sparita dalla scena. La cosiddetta matrigna Anne, progressista pura e un po’ volonterosamente fanatica, tipica americana bene (wasp: white, anglosaxon, protestant; ce ne sono a destra come a sinistra) vuole bene a Vera, la tratta come una figlia sua e come del resto tratta il proprio e più piccolo figliolo. Ma i due genitori, pur volendosi bene, litigano sempre; e Vera vorrebbe fare di tutto perché facciano pace. In più, comincia ad essere punta dal nostalgico e struggente desiderio di sapere qualcosa sulla sua vera madre scomparsa, e inizia le sue ricerche. Lo sfondo è un futuro prossimo, s’è detto. La spaccatura fra America conservatrice di casta pura e America liberal e progressista è sempre più netta. Anzi, a destra c’è una proposta di legge secondo la quale gli americani bianchi di successo che possono vantare una cittadinanza vecchia di duecento anni avranno un valore elettorale pari a un voto e mezzo invece che un solo voto come tutti gli altri. I progressisti insorgono, naturalmente. Nel frattempo l’Intelligenza Artificiale (IA) la fa ormai da padrona e invade tutte le sfere private e pubbliche e tecnologiche. Le automobili viaggiano da sole senza pilota e portano i bambini a scuola e i ragazzini possono dialogare con l’auto. Vera ha un amico importante che le hanno regalato, non è umano ma è una macchinetta tutta IA, e impersona un giocatore virtuale di scacchi il quale si chiama Kaspie (ironico riferimento al campione Kasparov) e gioca le partite con la bambina, battendola quasi sempre. Ma soprattutto Kaspie risponde a molte domande private, esistenziali di Vera e la consiglia, la mette in guardia, insomma è diventato un fidatissimo amico del cuore che lei consulta ogni sera nella propria cameretta. Per fortuna la ragazza ha anche una amica vera del cuore, una intelligente compagna di scuola giapponese. La forza spesso comica di questo romanzo sta nel linguaggio, nei dialoghi, tutti intessuti di espressioni “politically correct”, discorsi puliti, precisini, progressisti, permissivi, pacificamente severi; la mamma-bis è buona fino ad essere generosamente puntigliosa o noiosetta. Nel dissidio sociologico e culturale da classi alte fra la destra gelosa del proprio privilegio rassicurante americano e una sinistra liberal e multietnica e nutrita anche di belle utopie, si insinua il conformismo di un linguaggio politicamente corretto fino all’ossessione. Shteyngart non fa nessuno sconto ai radicalismi estremi e la sua prosa scoppietta di sarcasmo fine, caricaturale. Leggendo ci si diverte ma soprattutto ci rende empatici con Vera, che ha il diritto di conoscere la propria verità, e possibilmente di cercare di essere un po’ felice, a dispetto degli egoismi, dei radicalismi snob e delle macchine intelligenti.
Patrick Modiano
Einaudi
Patrick Modiano deve piacere. Se non piace, si dirà che è maniacalmente teso alla perlustrazione ossessiva della memoria di luoghi (solitamente una Parigi vera ma anche misteriosa) e di tempo (solitamente un passato soffuso, vago, perduto, ricercato solo a pezzi, nella vaghezza ambigua di ogni memoria remota). Se Modiano (fra l’altro premio Nobel per la letteratura nel 2014, insomma non un signor Nessuno) piace, allora il lettore diventa suo complice in tutte queste ricognizioni di memoria labile, in tutto questo rimpianto per il tempo che è passato per sempre e di cui restano reperti sparsi in una archeologia mnemonica i cui i ricordi sono macerie misteriose. Il monumento al tempo perduto è già stato eretto, nella letteratura francese, una volta per tutte, da Marcel Proust (voluttuosamente, superbamente, ossessivamente denso). Patrick Modiano non osa e nemmeno vuole sfiorare la maniacalità geniale di Proust. Egli costruisce invece in ogni suo breve romanzo un proprio personalissimo itinerario di ricognizione (di sostanza ma anche attentamente stilistico) per cercare tuttavia anche lui, se ci riesce, di fermare in qualche modo il tempo: “le temps perdu, le temps retrouvé”. In questa sua ultima fatica il premio Nobel francese evoca la figura misteriosa di una ballerina con cui l’io narrante ebbe, molti anni fa, un misterioso rapporto amoroso in una Parigi che oggi non c’è più, invasa com’è da masse errabonde e chiassose in un formicaio di turisti dagli sguardi pianificati e confezionati. Sono passati molti anni, la ballerina è scomparsa da qualche parte e da molto tempo, l’io narrante ricorda che lei era la mamma single di un bimbo di nome Pierre e ricorda che lui quel bambino ogni tanto andava a prenderlo in qualche casa per portarlo dalla mamma in qualche altra casa. E poi, soprattutto, lui andava ad aspettare la ballerina (di danza classica) all’uscita del teatro dove si provavano gli spettacoli, e dopo i due camminavano a lungo dentro una Parigi vivida e profonda in un reticolo di emozioni amorose e di strade e piazze note, bistrot odorosi, appartamenti caldi, botteghe, gente, personaggi oggi sfuggiti. Ancora una volta Modiano crea la sua topografia di luoghi e di tempi, ancora una volta la storia del passato è sfumata, persa nella bruma di una memoria labile e sensitiva. I pochi testimoni di oggi sono reticenti e vaghi, l’aria, le luci e gli odori di Parigi sono cambiati, la ballerina (amata, fuggita?) è stata risucchiata in un passato di cui chi scrive ha la struggente nostalgia che si può avere per una quasi felicità perduta, oppure soltanto per la giovinezza. Chi si ritrova un po’ in una sensazione come questa narrata da Modiano si godrà il romanzo, che chiude il sipario lasciando aperto il mistero. E quel lettore complice si munirà forse persino di una cartina di Parigi per seguire i percorsi e farà capo anche alla propria memoria visiva della città, se ce l’ha, o ripromettendosi di andare sul posto a inseguire il fantasma di un uomo che sta inseguendo il fantasma di una ballerina. Chi invece non bada a queste cose, un po’ forse si annoierà…
Emanuele Trevi
Solferino
Emanuele Trevi, scrittore che ama pescare con curiosità partecipe dentro le storie vere degli altri e anche in quelle del suo cerchio familiare e affettivo, questa volta racconta la storia dell’innamoramento di sua nonna. Una nonna vedova, “regina madre” dentro la sua antica dimora con annesso un misterioso giardino giù nella Calabria ancestrale, come fuori dal tempo. Questa nonna, chiamata Peppinella, vive e anzi regna su quella piccola porzione di civiltà in dissolvenza (un che di Magna Grecia, di lenti ritmi atavici) scortata da due singolari dame di compagnia, Delia e Carmela. E dunque lei, passati gli ottant’anni e diventata (ricorda il suo nipote scrittore) bellissima proprio a quell’età, all’improvviso incontra la figura aristocratica, distinta e un po’ patetica di un anziano Conte imparentato con tutto un mondo nobiliare di antico lignaggio. Quel Conte gentile coltiva come un collezionista compulsivo una sua passione inesausta per la storia dei Borboni, la monarchia sfiorita e decaduta del Regno delle Due Sicilie, dei Re di Napoli. Fra il Conte sussiegoso ed educato (un vero gentiluomo all’antica) e la nonna Peppinella nasce a poco a poco il bagliore di un incantesimo, di una attrazione che ha tutto dell’innamoramento ma viene anche contenuto nelle forme quiete, platoniche (ma non meno intense forse, di molte appassionate cotte giovanili) dettate dall’età tardiva. I due trascorrono ore liete, pensose o chiacchierate, seduti sulle seggiole di giardino o di casa, guardandosi e piacendosi e così fermando un poco l’inesorabile trascorrere del tempo che per loro non durerà moltissimo e poi continuerà senza di loro. Ma intanto si godono questa loro compagnia affettuosa, questa specie di comunione amorosa ben controllata e discreta, in cui l’uno è complementare all’altra e in due vivono l’ultima emozione di un ultimo amore (o quasi amore, chissà) senza smanie e senza complicazioni fisiologiche. Il nipote, che ama scendere in Calabria nella dolcezza anch’essa declinante degli ultimi tepori estivi di settembre per scrivere in tranquillità, nella casa della nonna è testimone di questa delicata storia di intimità senile ma non per questo meno bella e meno profonda. Trevi, per dirci questa storia, usa la musicalità piana e armoniosa di una scrittura attenta, minuziosa, mai smodata ma ammiccante, allusiva, e ci racconta gesti, parole, sentimenti percepiti e sensazioni, assieme a scorci splendidi di paesaggio e luci di una Calabria che riassume nel battito degli attimi del presente tutti gli esausti secoli della propria storia appartata e arcana. Le categorie che vengono in mente, per dare il tono di questo romanzo breve e bello, sono quelle della tenerezza e della malinconia, con tocchi di delicato umorismo. Quanto poi la storia sia andata proprio minuziosamente cosi, non è importante e non ci interessa. E del resto lo stesso autore, in un passaggio del racconto, ci avverte: “non c’è mai stato un sistema infallibile per separare la memoria dall’immaginazione – tanto che spesso la nostra vita mi sembra un miscuglio irreparabile di cose che crediamo di ricordare e di cose che crediamo di aver dimenticato”. Ovvero quando la memoria diventa letteratura.
Andrea Kerbaker
Guanda
George, signorile gentiluomo sulla novantina, infragilito dagli anni, un po’ stordito da ricorrenti vuoti di memoria, vive in una efficiente e soporifera casa di riposo per anziani nella campagna inglese. Solerti infermiere e infermieri lo trattano bene, se ne curano, lo scortano e lo blandiscono, alzando sempre un po’ troppo la voce (come si fa con tutti gli anziani, per eccesso di cautela a fronte di possibili cali uditivi). Ma a George manca l’aria intorno, lì dentro si sente atrofizzato e, memoria o no, capisce bene che quel luogo è l’ovattata anticamera della fine della vita. La dimora che lui ha dovuto abbandonare sta a poche fermate di bus dalla casa di riposo, in un borgo quieto. E George medita un elegante piano di fuga per tornare a toccare la realtà viva e perduta della sua “casa, dolce casa”. Questo è l’abbozzo e la sostanza stessa del delicato, aggraziato e malinconico romanzo breve di Andrea Kerbaker, scrittore e divulgatore culturale sessantacinquenne di Milano, con ascendenza britannica quanto basta per muovere il suo personaggio fra le colline inglesi. La trama del libro è felicemente lieve come la sua narrazione, il lettore cammina adagio con George, con lui attende trepidamente alla fermata del bus di poter quatto quatto tornare a toccare il cancello della sua cara casa, a varcare la porta della dimora dove ha vissuto anni pieni con la moglie, ora morta, e due bambine che adesso sono diventate adulte e abitano in giro per il mondo e vogliono molto bene al loro papà che però resta “depositato” in quella malinconica casa di riposo dove appena possono lo vengono a trovare ma insomma loro sono molto occupate con le loro vite e famiglie e carriere… Di per sé la vicenda (con la sua esile trama che lasciamo all’avventura della lettura) è abbastanza triste: la malinconica fragilità degli ultimi tratti del viale del tramonto e l’impotenza pigolante della vecchiaia avanzata e della memoria smarrita non mettono allegria, vero? Eppure Kerbaker sa speziare questa mestizia esistenziale con tocchi di empatia e sopratutto di lieve comicità, di piccoli stupori. Nel triste momento in cui si va verso l’epilogo della vita, la vita sembra dopotutto non perdere il suo gusto ineffabile. George vive e pensa, e ricorda, seppure in confusione, e gode e soffre e desidera come tutti, e persino si diverte, ammicca. Kerbaker usa il codice espressivo della tenerezza e della minuzia sensibile dei dettagli, in una continua identificazione compassionevole con George, il quale cerca di respirare ancora un po’ di vita vera. Vede luoghi, incontra persone, sa ancora stupirsi e desiderare. Molto bello è il suo rapporto empatico con una bambina appena conosciuta: due mondi, due epoche, due generazioni lontanissime tra di loro ma accostate in una fiduciosa attrazione. L’innocenza in bocciolo della bambina (che ha davanti a sé un lungo futuro in cui crescere) ha delle somiglianze con quel candore fragile che restituisce quasi una nuova innocenza a certi vecchi dal futuro cortissimo. Il tocco stilistico sapientemente leggero di Kerbaker manda luce buona su emozioni più profonde e sulle ombre ineluttabili della intrinseca drammaticità del vivere. Il soffio del desiderio ultimo di libertà e soprattutto la capacità di stupirsi e di sorridere di George salvano un po’ di bellezza malinconica dentro l’animo di quel gentiluomo smarrito e commuovono i lettori attenti di questo romanzo che, intendiamoci, parla del nostro possibile futuro…
Martin Suter
Sellerio
Ricordando "Il talento del cuoco", uno dei romanzi di Martin Suter, diciamo subito che in questo suo ultimo libro, “Melody”, c’è invece il talento della cuoca. La quale non è la Melody del titolo (no, Melody è la grande assente - ma presente intensamente - di tutto il libro) ma Mariella, cuoca zurighese di origine italiana che, assunta nella dimora sontuosa del ricchissimo, vecchio e malato Doktor Peter Stotz, gli prepara da anni le raffinate prelibatezze della cucina italiana. Questo signor Stotz è stato un ricamatore di potere nella Svizzera della politica, del denaro, degli affari. Colonnello dell’esercito elvetico, influente membro del parlamento svizzero, ha fatto parte di decine di consigli di amministrazione, da quelli commerciali, industriali e finanziari a quello prestigioso dell’Opera di Zurigo. Pieno di soldi, ha influenzato le grandi scelte dei poteri manifesti o occulti, da abile tessitore dietro le quinte. Ora, anziano e malato (dice di avere davanti a sé appena un anno di vita), nella sua bella e grande villa sulla collina dei ricchi zurighesi, circondato da domestici fidati, ha appena assunto un giovane giurista, Tom Elmer, brillantemente laureato ma ancora senza lavoro. Gli ha affidato la fatica di riordinare il suo immenso archivio privato, pieno di documenti pubblici e intimi, per confezionare un ritratto bello e gradevole da consegnare ai posteri. Tom Elmer, che per contratto deve abitare anche lui nella grande villa, viene costantemente invitato ai gustosi pranzi e cene di Stotz, il quale parla e parla, soprattutto davanti al camino, nelle lunghe soste per degustare preziosi cognac d’annata. E racconta, quasi a puntate, tutta la sua vita. Aggiungiamo che, oltre a mangiar bene, in quella casa si beve anche bene e soprattutto si beve molto: vini rossi pregiatissimi, champagne millésimé, cognac più vecchi del loro proprietario. Lungo il filo di tutta la narrazione spezzettata della vita del vecchio Stotz primeggia l’aura misteriosa e affascinante di Mélody, una giovane donna che deve essere stata molto bella a giudicare dai numerosi ritratti e dalle numerose fotografie appesi qua e là sulle pareti delle stanze della villa, quasi come sacre icone. Melody è stata il grande amore di Stotz. Ma non c’è. Dove sarà mai? Qui sta il mistero del romanzo, che mi guardo bene dallo svelare perché uno dei meriti di Martin Suter (da cui il suo successo editoriale internazionale) è proprio quello della tensione del “plot”, ovvero della forza di mistero e suspense delle sue sue storie. Forse persino troppo, giacché dopo una prima parte di raffinata ambientazione e di ironici tratteggi di persone, il finale si concede in modo un po’ convulso al gomitolo ingarbugliato di una trama da “giallo” senza pause. L’atmosfera della villa e l’abitudine al potere del vecchio Stotz sono i fattori più avvincenti del romanzo, assieme ai profumi della cucina di Mariella e agli effluvi dei vini. Altri due punti a favore del libro: la critica sottile alla casta dei poteri forti elvetici, in una Zurigo di banche, ville, ristoranti celebri, colonnelli, politici, affari, denaro, egoismi. Un altro aspetto è curioso e appare come un ammiccamento dello scrittore: nelle narrazioni del vecchio Stotz, ovvero nella sua versione della verità, non si riesce a capire dove finisca la realtà e dove inizi la finzione. Ma quando si raccontano storie, suggerisce a questo proposito un personaggio del romanzo, il confine fra finzione e realtà è sempre labile, ineffabile, sfuggente. Tale e quale la letteratura… La scena del romanzo è Zurigo, ma con puntate qua e là, a Singapore, persino ad Ascona, sul Monte Athos e soprattutto sulle isole greche. Un po’ troppo guida turistica? Forse. Ma Martin Suter possiede certamente l’ottimo artigianato del mestiere di narratore: con qualche limite di cui s’è detto, il suo romanzo si beve con gusto, così come con gusto bevono ogni giorno i personaggi della storia nella sontuosa villa sulla collina della ricca borghesia zurighese.
Giorgio Montefoschi
La nave di Teseo
Torna Montefoschi, torna Roma borghese, tornano a soffiare i venti di scirocco e di libeccio sulle care strade, le piazze, gli scorci, gli slarghi e i parchi, sotto cieli cangianti, dentro le luci di meriggi e tramonti. Riecco i personaggi di Montefoschi, alto-borghesi, intellettuali, un po’ esausti e fiaccati da una vita senza forti colpi ma anche senza ardimenti liberati: piane esistenze ben controllate, ingegni e saperi, vecchie abitudini (giornali buoni, aperitivi, i soliti bar, letture, amori limpidi o pasticciati). Questa volta entra in scena Pietro, scrittore affermato che va verso i settanta, stanco di scrivere (di vivere?) con un romanzo pronto ma che non vuole più pubblicare. Un po’ svuotato, ecco. Lo preme da Milano (e scende a Roma a dirglielo) Mario, l’amico editore. Lo preme anche una nuova arrivata, la più giovane Paola, editor della casa editrice, la quale accende in Pietro la scontata, cauta o concitata attenzione maschile, ovvero del maschio tardivo che vuol trattenere la sensualità prima del declino definitivo. Pietro (che conduce una calma relazione intermittente, senza convivenza, con Sabina, madre di una adolescente), si sente attratto da Paola, la quale risponde con alternanti mosse di seduzione e di fuga. Si gioca così una quieta trama di piccoli passi esistenziali e sentimentali che sembrano qua e là dei passi d’addio (il tempo si fa breve, ormai). La storia narrata in sé potrebbe anche non essere decisiva, per il lettore. Decisivo è il modo con cui Giorgio Montefoschi, ancora una volta, avvolge la trama dentro il mondo fisico e sensibile del suo paesaggio urbano romano. Da tempo, da quando leggo i suoi romanzi, sostengo addirittura che Giorgio Montefoschi divide: può piacere o non piacere, può intrigare oppure persino stancare il lettore che non voglia abbandonarsi allo stile tutto particolare, originale, riconoscibile, della sua scrittura. Io trovo che ci sia in essa un magnetismo avvolgente, quasi una musicalità morbida, fatta di motivi ripetuti, brevi passaggi e raccordi insistiti dentro un realismo puntiglioso di dettagli. Un vezzo singolare della sua prosa precisa e impressionistica è quello di darci tutti i dati topografici di ogni scena, in una ossessione che alla fine si trasforma in un sottofondo melodico per la scansione dei gesti e dei dialoghi: di ogni spostamento dei protagonisti sappiamo gli orari, spesso addirittura le date, le strade percorse, gli angoli di vie e di piazze, i colori del cielo, la corsa delle nuvole, e poi i bar, i chioschi, i luoghi delle cene dentro una Roma borghese oppure sul litorale marino romano di Sabaudia e dintorni. Sappiamo tutto, dei fondali narrativi: le luci soffuse e arancioni dei lampioni nel crepuscolo, i colori delle stagioni, lo scorcio dal Pincio sui tetti e le cupole e poi la geografia circostanziata dei quartieri ricchi e borghesi, placidi (e anche più celebri luoghi) con tutta la nomenclatura precisa di quella topografia reale e letteraria al tempo stesso. In quello scenario dettagliato (volutamente ripetitivo: certi spostamenti abituali sono ridetti decine di volte creando una familiarità complice di gesti quotidiani) si muove la storia personale dei personaggi: i quali, calati in una vellutata compagnia rarefatta di pochi affetti e amici e qualche stanchezza consolata da buoni bicchieri e buone abitudini, spesso sentono il morso della solitudine. O è il morso della ineluttabilità del tempo che passa e, appunto, si fa breve?
Eshkol Nevo
Feltrinelli
“La simmetria dei desideri” è il titolo di un fortunato e bel romanzo di Eshkol Nevo. Una certa asimmetria, invece, di desideri, sembrerebbe caratterizzare molti dei racconti dello stesso scrittore, appena tradotti da Feltrinelli. “Legàmi” è il titolo, che evoca le intime, complicate e spesso conturbanti connessioni delle trame affettive. Molto spesso la presenza del desiderio (essere amati, amare, essere addirittura felici) coincide con una dissonanza fra desiderio e desiderio, o quantomeno rivela tempistiche diverse fra i protagonisti. E tuttavia i legami affettivi (familiari, di amicizia, sessuali, psicologici, eccetera) sono la nervatura portante, a guardar bene, della società, prima ancora dei grovigli relazionali pubblici della società stessa. È nel cerchio ristretto degli intrecci affettivi privati che covano le trafitture esistenziali, le speranze e le disillusioni di uomini e donne che poi, tutti insieme, fanno la società. Nella seconda di copertina l’editore pone l’accento insistito proprio sulla centralità del desiderio, in questi racconti dello scrittore israeliano, al pari di tutti gli altri libri dell’autore. È un po’ vero ma penso tuttavia che quei racconti contengono tutte le piste relazionali e complesse dei legàmi affettivi, fra le quali il desiderio è una componente ma non necessariamente dominante. Ci sono anche le stanchezze affettive e le asimmetrie sentimentali (appunto), la fatica di sbarcare il lunario familiare, i gorghi consci e inconsci fra genitori e figli, poi la tenerezza, la dolcezza dell’abitudine collaudata negli amori longevi e, per contro, il delicato strazio dei distacchi. Sono racconti abbastanza brevi e fulminanti, quelli di Nevo. Vi accadono fratture e turbamenti, piccoli colpi di scena, minimi tracolli dei destini. Vi si inseguono possibili felicità (sì, appunto, il desiderio), si stemperano delusioni, sfrigolano caratteri. È la danza della vita. Nevo la conduce con linguaggio veloce e preciso, dando alla narrazione ritmo anche visivo (molti gli a capo, le pause grafiche). È una attualità sentimentale in presa diretta, una cronaca quotidiana della confusa geografia degli affetti: fra mariti e mogli, fra genitori e figli, fra amici e amanti, in plurime età e situazioni. La misura del racconto impedisce a Nevo di affondare la sonda psicologica in nature e trame più durature, ovvero nella forma del romanzo che gli conosciamo e abbiamo apprezzato. Qui va più spedito, talvolta si vorrebbe che si fosse soffermato di più, qualche racconto richiederebbe ossigeno in aggiunta per continuare a spiare i vizi e le virtù dei personaggi alle prese con i giochi di carte del destino. Quel che è certo è che Nevo sembra nato apposta per narrare. Lo sfondo della contemporaneità israeliana è proprio, questa volta, soltanto uno sfondo sfocato (peraltro i racconti sono stati pubblicati da Nevo in lingua ebraica l’anno scorso ma prima della tragedia del 7 ottobre e di tutte le sue conseguenze). Stavolta la scenografia narrativa di Nevo è un lungo seguito di molteplici interni familiari o affettivi. I legàmi, appunto.
Matteo Terzaghi
Quodlibet
Si intrecciano in una cadenza quasi musicale i racconti (schizzi, apologhi, divertissements, bagliori narrativi) di Matteo Terzaghi raccolti in questo volume dalla struttura ironicamente e affettuosamente didattica. Si va per capitoli generali (“Manuali, enciclopedie, favole”, “Piccolo libro di lettura a uso di chi passa”, e “Altra infanzia”). In apertura, quasi come un piccolo avanspettacolo, c’è un raccontino intitolato “Si comincia con un funerale”: una visione un po’ felliniana in cui il passo malinconico del corteo funebre si trasforma in una ballata allegra e magica, liberatoria. Il pretesto d’avvio dell’autore è la sua curiosità per i celebri manuali Hoepli (il mitico libraio ed editore svizzero in Italia). Manuali su tutto lo scibile umano, perfino sui “duelli”, “sui cavi telegrafici sottomarini”, “sull’industria dei fiammiferi e del fosforo”… Da lì parte Terzaghi, raccontando con precisione e con humor sottile la storia dei fiammiferi e del fosforo per il quale si accende la capocchia dei suddetti, fino poi alla decadenza del fiammifero stesso, sconfitto dagli accendini. La prosa di Terzaghi è calcolatamente semplice, lieve, e nondimeno sapientemente impregnata di piccoli affondi preziosi (come fiammiferi che si accendono improvvisamente, ecco). Esempio: “L’invenzione dei fiammiferi ha portato allo spegnimento di molti fuochi, perché con i fiammiferi la necessità di conservare la brace nei focolari per potervi attingere una fiamma in qualsiasi momento è venuta meno. Il fuoco si è allontanato dall’esperienza quotidiana, si è estinto come conseguenza del fatto di poter essere acceso, all’occorrenza, con la massima facilità”. Questo pensiero si attaglia a molte altre invenzioni che conquistano qualcosa ma spesso danneggiano qualcosa d’altro. Prendiamo l’invenzione del telefono. Utilissima per carità, come già esclamava in un suo opuscolo del 1886 l’ingegner Michele Patocchi (“il telefono ogni giorno si moltiplica, si ramifica, s’estende ed invade il mondo”). Ma già nel 1880 il pittore Degas, racconta Paul Valéry, un giorno aveva deriso un amico che era scattato in piedi con la prontezza di un servo per rispondere allo squillo del telefono: - c’est ça le téléphone? On vous sonne, et vous y allez“. ”Oggi”, soggiunge Terzaghi, “sappiamo quali progressi avrebbe poi fatto la telefonia cent’anni dopo, congiungendosi con l’informatica, nell’asservimento degli esseri umani”. E qui capiamo come l’autore mantenga un suo malinconico scetticismo su certo “magnifico” progresso di una umanità sempre più indaffarata, affrettata, eccitata. Si intuisce che Matteo Terzaghi, progressista su certe cose, per certe altre è un conservatore giudizioso. Anche nel capitolo “Piccolo libro di lettura a uso di chi passa” (un invito a sostare, a sillabare storie minime) scopriamo personaggi divertenti, allusivi, o misteriosi, sempre un po’ dismessi, laterali rispetto al corso consueto delle cose. Come l’accordatore di pianoforti, per il quale “i pianoforti sono delle macchine perfettamente autonome, funzionano anche durante i black out, anche quando crolla il mondo” (e peraltro secondo lui “la musica non serve a niente, è il suo bello”). E l’accordatore, coerentemente con il suo pensiero, sale e scende a piedi nei caseggiati senza prendere l’ascensore. C’è la vecchia signora che nel suo appartamento ha radunato centinaia di sassi, ognuno preso nel corso della sua lunga vita da luoghi dove lei era stata felice, e alla sua morte alcuni operai caricano a badilate la montagna di sassi (che hanno perso la loro vita) su un camioncino. Poi c’è il dandy un po’ sdrucito che impersona Diogene, la giovane farmacista che impacchetta una medicina con tale cura al punto di fare innamorare il cliente e incartargli bene la sua felicità, e tante altre piccole storie che ricordano la grazia ilare o stralunata o malinconica del Marcovaldo di Calvino: minuscoli apologhi narrati con tenerezza e con leggerezza (anch’essa calviniana). E poi, ancora: memoria di uno scrittore caro, bizzarri ricordi postali, un eremita enciclopedico in valle Onsernone, e altro. Nel capitolo “Altra infanzia” si capisce bene che nell’età d’oro della vita ci si impregna di sensazioni, visioni, immagini che poi saranno fieno in cascina per tutta la vita. Si va dai vividi ricordi di nonni e nonne e zii stravaganti alle mitiche attraversate del passo del San Gottardo stipati in una Peugeot 404 azzurro cielo, fino ai primi impatti del ragazzino con il dolore e la morte (un braccio ferito, un gallo decapitato). C’è posto anche per la stagione intuitivamente creativa dei bambini, quando il figlio dello scrittore a cinque anni se n’era uscito con questa perfetta definizione: “i sogni sono dei filmini nell’aria”. Ecco dunque un divertente e anche malinconico, intenerito, preoeccupato libro di impressioni narrate con raffinatezza: un manuale sulla vita, ecco.
Hilma Wolitzer
Mondadori
Allegra e malinconica, ilare e drammatica, divertita e tormentata, sottile e profonda: eccola qui, Hilma Wolitzer, scoperta o riscoperta editoriale in lingua italiana (c’erano stati anni fa due romanzi tradotti, almeno uno è ancora in commercio) di una scrittrice statunitense feconda e longeva, tenera e impertinente. Oggi lei ha 94 anni. Ciò che stupisce, nella raccolta di racconti (ma con un filo continuativo da romanzo) pubblicata pochi mesi fa da Mondadori in italiano, è che il primo racconto è del 1966 (un’epoca storica fa, quasi) e l’ultimo è del 2020 (contemporaneo, in piena epidemia di COVID). La prefazione entusiasta e solidale di questo libro è di Elizabeth Strout, grande signora del romanzo americano. Si diceva della ambivalenza cangiante degli umori e delle esperienze narrate di questa scrittrice che intreccia ironia e tristezza: già il titolo della raccolta (”Oggi una donna è andata fuori di testa al supermercato”, esattamente tradotto dall’inglese, “Today a Women Went Mad in the Supermarket”) sembra umoristico ma sintetizza il momento poco allegro di uno smarrimento depressivo. Quasi tutti i racconti sono legati tra loro come un romanzo a periodi, un viaggio diaristico dentro gli anni, da quelli freschi a quelli della vecchiaia (le vicende di una coppia e dei loro figli). Fanno eccezione un paio di racconti con altri personaggi, dove c’è un cambio di identità ma non di stile e originalità. La prima persona narrante del filo continuativo è una donna che si racconta dentro il cerchio della propria intimità, dei propri affetti privati, delle proprie letizie e inquietudini. Formidabile (e raccomandabile a noi lettori maschi) il racconto della nascita del primo bambino, con tutta la cronaca di prima, durante e dopo il parto e tutte le implicazioni di attesa eccitata, paure, ironia psicosociale, con leggerezza e profondità, a conferma della sapiente doppia velocità umorale dell’autrice. Poi c’è l’amore sentimentale, c’è il rapporto con il suo uomo e padre dei suoi figli, la vita domestica, le serenità e le depressioni, l’insonnia e lo scontento, gli anni che passano, i vecchi genitori infragiliti e poi la stessa coppia protagonista che a sua volta invecchia e si ritrova negli anni ultimi e faticosi della vita. Qui ci sta una citazione. Siamo appunto al momento in cui la coppia coniugale è ormai molto anziana, con i figli adulti e fuori casa e loro stessi già genitori, e lei ogni mattino aprendo gli occhi verifica che il marito che le dorme accanto sia ancora vivo….: “Ogni volta che lo vedevo respirare e che l’aria del mattino era in agguato dietro le tende pronta a invadere la stanza, provavo un moto irragionevole di felicità. Un altro giorno! E poi un atro, un altro e un altro ancora. Colazione, vitamine, bollette, discussione, pillole per la pressione, pranzo, medico, integratore per il colesterolo, il telefono, cena, tv, pillole per dormire, sonno, sveglia, sembrava che potesse andare avanti in eterno in quel modo squisitamente e splendidamente noioso. Ma non era così, ovviamente, come tutti sappiamo”. Vedete che c’è dentro tutto? La divertita caricatura della fragilità senile e il rintocco drammatico del fatale declino dietro l’angolo. Wolitzer non si ferma qui e aggiunge una frecciata ironica e malinconica: “C’era uno schema con le varie pillole e ricostituenti attaccato al frigorifero con un magnete, dove una volta mettevamo i disegni dei bambini e poi dei nipoti”. Una frase, ed è tutta una vita.
Tutti gli altri libri presentati li trovate nella pagina Recensioni